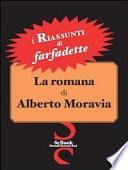
Cerca negli ebook:
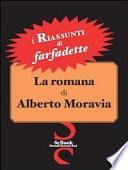

Alberto Moravia in Italia
Autore: Ferdinando Alfonsi
Numero di pagine: 206
Come leggere Gli indifferenti di Alberto Moravia
Autore: Marinella Mascia Galateria
Numero di pagine: 102
Alberto Moravia
Autore: René De Ceccatty
Numero di pagine: 1000Tra il 1929, anno di pubblicazione del suo primo romanzo, Gli indifferenti, e il 1990, quando improvvisamente scompare nella sua casa romana, Alberto Moravia osserva l’Italia, viaggia in un mondo di cui analizza l’evoluzione catastrofica e partecipa all’elaborazione del romanzo moderno. Scrittore precoce – a diciassette anni comincia la redazione di un romanzo considerato un capolavoro assoluto –, ottiene una notorietà immediata. Antifascista, coraggioso difensore delle sue posizioni intellettuali, Moravia è perseguitato dalle leggi razziali prima e durante la guerra, ma riesce ugualmente a pubblicare. Dai suoi romanzi di successo (Agostino, Il conformista, Il disprezzo, La noia) sono tratti film che ne consolidano la notorietà. Grande reporter, segue da vicino i maggiori avvenimenti del XX secolo, raccontati attraverso testimonianze da Stati Uniti, India, Cina, Giappone, Unione Sovietica e Africa. Distinguendo sempre la ricerca artistica dall’impegno politico, che esige altre azioni e altri linguaggi, la sua opera e il percorso della sua vita rivelano una personalità che vuole affrancarsi dalle origini borghesi: “L’anormale ero io” scriverà. La sua vita...
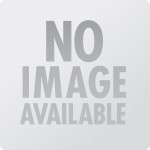
Alberto Moravia. Con CD Audio
Autore: Maria Angela Cernigliaro

Alberto Moravia. Poesie
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 207Alberto Moravia si è dedicato alla poesia da ragazzo. Erano poco noti i testi poetici più tardi, scritti tra gli anni settanta e i primi anni ottanta. Le ottantatré poesie di questa raccolta, in gran parte inedite, allargano gli orizzonti dello sguardo artistico di un autore di cui tanto è stato detto e scritto, e che pure non smette mai di affascinare la critica e i lettori. Sono testi intimi che dialogano con il resto della sua opera perché attraversati da una riflessione sulla letteratura avviata in una fase matura della vita. Vi tornano costanti alcuni temi tipicamente moraviani – l’eros, il viaggio, il rapporto tra natura e storia, il passato e la memoria – affrontati nella forma di un diario personale in cui riprendere contatto con la parte più giovane di sé. Moravia si abbandona alle emozioni, le libera in versi narrativi che rinviano ai grandi argomenti metafisici, a cominciare dal tempo, per parlare poi del mondo, della passione, degli amori: a esplicita dimostrazione del suo profondo interesse per la poesia, manifestato anche come autore di racconti e romanzi in cui versi isolati o interi componimenti contribuiscono alla costruzione della trama.
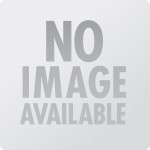
Alberto Moravia. Il primo e l'ultimo
Autore: Roberto Granata
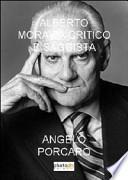
Alberto Moravia critico e saggista
Autore: Angelo Porcaro
Numero di pagine: 107
Un'idea dell'India
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 156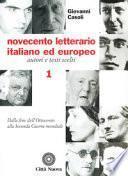
Novecento letterario italiano ed europeo
Autore: Giovanni Casoli
Numero di pagine: 926
Alberto Moravia
Autore: Oreste Del Buono
Numero di pagine: 217
Alberto Moravia e il cinema. Una rilettura storica
Autore: Silvia Serini
Numero di pagine: 134
Nuovi Argomenti (40)
Autore: AA.VV.,
Numero di pagine: 320Alberto Carocci e Alberto Moravia fondano Nuovi Argomenti. «L'idea», ricorderà Moravia, «era quella di creare una rivista di sinistra come "Temps Modernes" di Sartre, la quale avrebbe avuto un'attenzione per la realtà italiana di tipo oggettivo e non lirico». Il bimestrale ha la sua redazione in via dei Due Macelli 47 (segretario di redazione, Giovanni Carocci) e viene stampato presso l'Istituto Grafico Tiberino di Roma. Hanno collaborato: Antonio Debenedetti, Raffaele Manica, Rossana Campo, Paola Capriolo, Angelo Ferracuti, Giuseppe Genna, Nicola Lagioia, Valerio Magrelli, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Valeria Parrella, Antonio Pascale, Lorenzo Pavolini, Claudio Piersanti, Elisabetta Rasy, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Walter Siti, Enzo Siciliano, Paolo Di Paolo, Antonio Debenedetti, Gianluca Lauta, Luca Serianni, Riccardo Tesi, Antonio Debenedetti, Maria Laura Gargiulo, Giovanna De Angelis, Andrea Caterini, Emiliano Sbaraglia, Alessandro Marongiu, Chiara Valerio, Giancarlo Liviano D'Arcangelo, Joyce Carol Oates, Vincenzo Pardini, Beppe Sebaste, Carlo Bordini, Adelelmo Ruggieri, Matteo B. Bianchi, Franco Arminio, Alessio Pasa, Inna L'vovna Lisnianskaja, Ulrike...

Alberto Moravia e l'alienazione
Autore: Bruna Baldini Mezzalana
Numero di pagine: 249
Alberto Moravia e gli indifferenti
Autore: Rocco Carbone
Numero di pagine: 124
Racconti di Alberto Moravia
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 227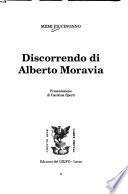
Discorrendo di Alberto Moravia
Autore: Memi Piccinonno
Numero di pagine: 101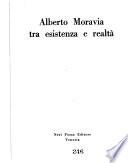
Alberto Moravia tra esistenza e realtà
Autore: Alberto Limentani
Numero di pagine: 138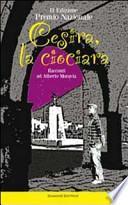
Cesira, la ciociara. Racconti ad Alberto Moravia
Autore: Fondazione Moravia
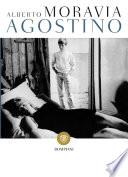
Agostino
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 186Quando nel 1944 Alberto Moravia tornò a Roma, al seguito delle truppe alleate, era praticamente un autore che ricominciava, anzi cominciava in quello stesso momento. Il romanzo breve Agostino fu il capolavoro che gli consentì di conquistare i riconoscimenti della critica e del pubblico. Agostino è la storia di un’iniziazione sessuale. Da una parte, un ragazzo di tredici anni che è ancora un bambino; dall’altra la madre, vedova, ma ancora fiorente e desiderosa di vivere.Durante una vacanza al mare i rapporti tra il figlio e la madre si guastano, si corrompono d’inquietudine. Per il ragazzo sarà necessario approdare a un’autentica crisi, una lacerazione che gli consentirà di ripartire poi a ricomporre il mondo, a farsi una ragione della vita.Con Agostino, ritorno alla narrativa vera e propria dopo evasioni e sfoghi surrealisti e satirici, Moravia conquistò il suo primo premio letterario.NUOVA EDIZIONE A CURA DI SIMONE CASINICON TESTI DI UMBERTO SABA E CARLO EMILIO GADDADISEGNI DI RENATO GUTTUSO

La mia Africa con Alberto Moravia
Autore: Lorenzo Capellini
Numero di pagine: 207
Alberto Moravia, vita, parole e idee di un romanziere
Autore: Enzo Siciliano
Numero di pagine: 252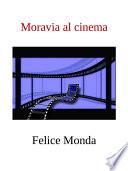
Moravia al cinema
Autore: Felice Monda
L'opera tenta di estrapolare l'idea di cinema di Moravia analizzando alcune delle sue recensioni apparse su L'Espresso. Moravia preferisce il cinema d'autore al cinema commerciale: “perché i film commerciali posseggono una metafora, sola e scontata, quella del denaro e del successo”. Per Moravia il cinema è arte e nel dire questo egli pensa ai film come opere letterarie alla pari di poesie e romanzi. Per Moravia la letteratura si giova della parola mentre il cinema dell’immagine...

E così vorresti fare lo scrittore
Autore: Giuseppe Culicchia
Numero di pagine: 208Un vademecum semiserio, anzi serissimo, sulla fenomenologia dello scrittore italiano: Brillante Promessa al primo libro, Solito Stronzo dal secondo libro in poi, Venerato Maestro nella fase senile. Culicchia dà utili consigli su come gestirsi in società (letteraria): cosa aspettarsi e non aspettarsi dal proprio editore, dalla critica, dai lettori. Viene fuori un interessante bestiario di personaggi-tipo e un nuovo modo di stare sulla scena letteraria. Paolo Di Stefano, "Corriere della Sera" L'incursione di Culicchia nella cosiddetta filiera del libro è amara: con il suo sarcasmo e con una punta di ironico cinismo, la denuncia vira verso il disincanto. Andrea Bajani, "la Repubblica" Un'opera socialmente utile che rivela agli aspiranti scrittori tutto quello che avrebbero voluto sapere (e che non hanno mai osato chiedere alla Holden). Gabriele Ferraris, "Tuttolibri" Ecco una serie di consigli su come 'tirarsela' nei salotti e in Rete: tra gli altri avere uno sguardo alla David Foster Wallace, citare Dfw, imitare la voce di Dfw, cucinare come Dfw, rammaricarsi della scomparsa di Dfw. Filippo La Porta, "Left"
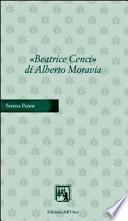
Beatrice Cenci di Alberto Moravia
Autore: Serena Penni
Numero di pagine: 155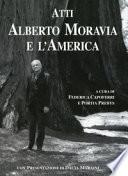
Atti di Alberto Moravia e l'America
Autore: Dacia Maraini
Numero di pagine: 433
Alberto Moravia, vita, parole e idee di un romanziere
Autore: Enzo Siciliano
Numero di pagine: 252
I fantasmi del fascismo
Autore: Simon Levis Sullam
Numero di pagine: 208Questa storia ha quattro protagonisti: lo storico Federico Chabod, il giurista Piero Calamandrei, il critico letterario Luigi Russo e lo scrittore Alberto Moravia. Quattro grandi intellettuali che, noti antifascisti nel dopoguerra, mantennero durante il fascismo un atteggiamento perlopiù di cautela e inazione politica, talora con cedimenti rispetto alla collaborazione al regime. Nell’immediato dopoguerra essi tesero invece a ridefinire e riscrivere il proprio precedente percorso rappresentandolo sempre coerentemente improntato all’antifascismo. Se l’intellettuale viene solitamente immaginato come anticonformista e critico del potere, in realtà tende spesso ad adeguarsi alla maggioranza e a esprimerne gli orientamenti. Contano i condizionamenti politici e istituzionali, per esempio del sistema universitario, o delle istituzioni culturali in cui operano; conta l’esigenza di affermarsi sul piano culturale o artistico. Conta, in ogni tempo, anche la tendenza dell’intellettuale a dar voce e interpretare i sentimenti della maggioranza e talora cedere al potere. L’autoassoluzione degli intellettuali italiani rispetto alla propria implicazione con il fascismo ha tuttavia...
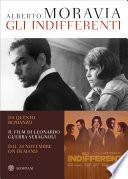
Gli indifferenti
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 269Quando Alberto Moravia cominciò a scrivere questo capolavoro, nel 1925, non aveva ancora compiuto diciott’anni. Intorno a lui l’Italia, alla quale Mussolini aveva imposto la dittatura, stava dimenticando lo scoppio d’indignazione e di ribellione suscitato nel 1924 dal delitto Matteotti e scivolava verso il consenso e i plebisciti per il fascismo. Il giovane Moravia non si interessava di politica, ma il ritratto che fece di un ventenne di allora coinvolto nello sfacelo di una famiglia borghese e dell’intero Paese doveva restare memorabile. Il fascismo eleva l’insidia moderna dell’indifferenza a condizione esistenziale assoluta.
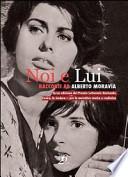
Noi e lui. Racconti ad Alberto Moravia
Numero di pagine: 144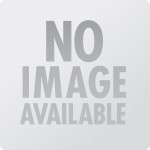
Alberto Moravia
Autore: Edoardo Sanguineti
Numero di pagine: 155
Moravia. I racconti 1927-1951
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 626Questo volume, pubblicato originariamente nel 1952, raccoglie gran parte dei racconti scritti da Moravia tra il 1927 e il 1951, alcuni già apparsi su giornali e riviste e tutti (tranne l’ultimo, Luna di miele, sole di fiele) distribuiti in raccolte più brevi come La bella vita (1935), L’imbroglio (1937) e L’amante infelice (1943). I primi racconti risalgono agli anni in cui Moravia lavorava a Gli indifferenti (1929) e mostrano già la compiuta maturità tecnica ed espressiva dell’autore. La raccolta, che ottenne il Premio Strega nel 1952, comprende inoltre alcuni tra i suoi racconti lunghi più noti, come Cortigiana stanca, Delitto al circolo del tennis, La provinciale, Fine di una relazione. Sono testi che collocano Alberto Moravia in una posizione di assoluto rilievo nel panorama letterario italiano del Novecento: i racconti hanno spesso un’ambientazione medio-borghese, che Moravia ben conosceva e spesso stigmatizzava e rivelano un mondo di relazioni ipocrite, basate sul potere cinico del denaro, sulla reciproca indifferenza e su rapporti amorosi spesso insinceri e viziati da altre finalità. Moravia ci restituisce personaggi alle prese con i dubbi e le ambiguità di ...
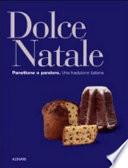
Dolce Natale
Autore: A. Lo Russo
Numero di pagine: 175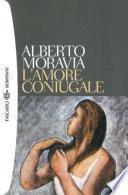
L'amore coniugale
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 151L’amore coniugale è la storia di un uomo che cerca al tempo stesso di essere buon marito e buon scrittore, finendo col fallire entrambi gli obbiettivi: il fallimento erotico-sentimentale da un lato e il fallimento letterario dall’altro. Il contrasto tra vita affettiva e vita culturale è affrontato in tutta la sua crudezza, con la tipica capacità di Moravia di racconatare, senza reticenze, e di fare emergere un discorso civile e morale. Pubblicato per la prima volta nel 1949, è tra i romanzi più vivi e impegnati di Moravia

Dormono sulla collina. 1969-2014
Autore: Giacomo Di Girolamo
Numero di pagine: 1272Questo libro si pone un obiettivo smisurato: il nostro paese raccontato da chi dorme, e sempre dormirà, sulla collina. Siamo di fronte alla Spoon River d’Italia. Il paese lo raccontano loro: gli uomini che sono passati di qui, quelli che hanno fatto la storia oppure che l’hanno subita. Gli uomini che tutto sapevano e nulla rivelarono. Gli uomini che nulla sapevano e tutto rivelarono. Uomini magniloquenti, uomini magnifici, uomini miserabili. Uomini piccoli e piccoli uomini. Volti imperiosi e notissimi, volti arcaici, che hanno fatto un qualche frammento di storia, anche se nessuno lo sa. Sono le loro voci a fare la storia. Dov’è Pino Pinelli, l’uomo che non voleva volare? Dov’è il poeta, Giuseppe Ungaretti? S’illumina ancora di immenso? Dove sono Anna Magnani, quelli di Piazza della Loggia, le vittime del terremoto dell’Aquila? Dove il piccolo Samuele di Cogne, dove Marco Pantani, dove Giulio Andreotti? Il generale Dalla Chiesa? Dormono, dormono sulla collina. E non solo loro. Programmi televisivi, bombe che esplodono, decreti legge. Anche gli oggetti. Gli oggetti sono così silenziosi, ma sanno tutto di noi, e fanno la storia. Anche loro: dormono sulla collina....

Casa museo Alberto Moravia
Numero di pagine: 144
Alberto Moravia. L'attenzione inesauribile
Autore: C. Bertoni , C. Lombardi
Numero di pagine: 198
Romanzi e racconti, 1941-1949 - 3. Romanzi e racconti, 1950-1959 (2 v.)
Autore: Alberto Moravia
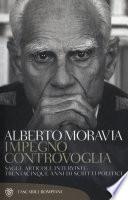
Impegno controvoglia
Autore: Alberto Moravia
Numero di pagine: 380"Il Moravia ’politico’ riflette sui temi pubblici dell’attualità contemporanea la stessa situazione che il Moravia ’scrittore’ indaga sul piano privato e interiore dei personaggi. I saggi politici tendono ad esplicitare e a ridurre il contrasto che nell’opera narrativa è implicito e fecondo, formulando da un lato la denuncia di un orizzonte ristretto e sostanzialmente borghese, e manifestando dall’altro lato la tensione utopica verso alternative possibili. È questa dialettica profonda a caratterizzare l’engagement di Moravia, che dunque si muove tra la polarità negativa del ’già visto’, entro cui si iscrivono esperienze oppressive pur tanto diverse tra loro quali il vittorianesimo, il fascismo, lo stalinismo, e la polarità positiva del nuovo e del ’mai visto’, che ha qui una sorta di suggestivo e precoce manifesto nel saggio del 1944 su La speranza, ovvero cristianesimo e comunismo e che Moravia addita poi, con un entusiasmo talora disarmante, in esperienze storiche come la rivoluzione culturale cinese, oppure la contestazione studentesca del Sessantotto o, in una diversa accezione, l’emergenza del Terzo Mondo. Tra il saggio del 1944 e l’anelito...
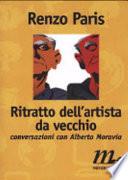
Ritratto dell'artista da vecchio
Autore: Alberto Moravia , Renzo Paris
Numero di pagine: 171Vedi maggiori dettagli