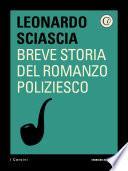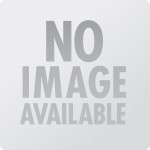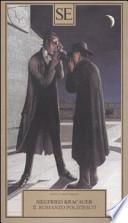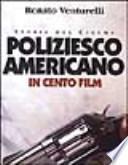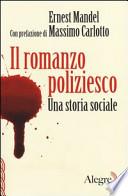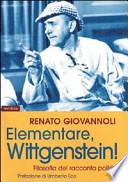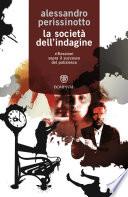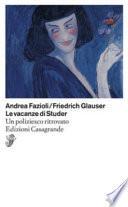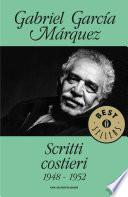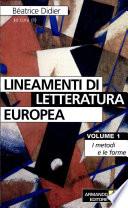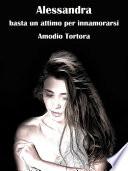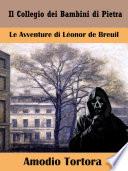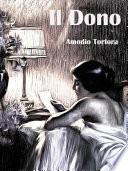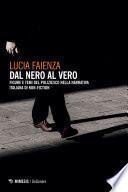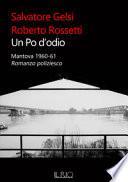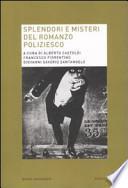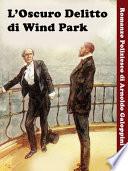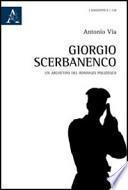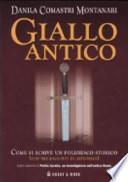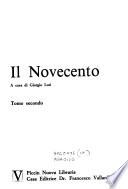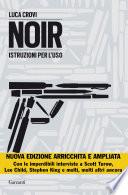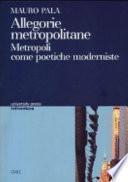Il romanzo poliziesco contemporaneo tra tensione morale e impegno sociale
Autore: Dina Lentini
Numero di pagine: 227Saggi - saggio (227 pagine) - Saggi su Maj Sjöwall e Per Wahlöö, Anne Perry, Claude Izzo, Alicia Gimenéz Bartlett, Qiu Xiaolong, Moussa Konaté La storia del romanzo giallo ha seguito la storia dello sviluppo della società borghese, e con essa si è evoluta a partire dai classici fra `800 e `900, fino alla dilagante serie di opere contemporanee che hanno invaso il mercato librario internazionale coinvolgendo un’area immensa di pubblico. Se inizialmente la produzione e la fruizione del giallo finivano per collocarsi tra Europa continentale e America, oggi gli spazi della detective novel si sono praticamente moltiplicati in ogni direzione, dal grande Nord all’area mediorientale, all’Africa, all’Asia. La dilatazione geografica e culturale connessa alla distruzione degli stati e delle economie nazionali iniziata nell’ultimo trentennio del secolo scorso ha inciso anche in questo campo. Dalla Svezia di Maj Sjöwall e Per Wahlöö alla Londra vittoriana di Anne Perry, dal Noir mediterraneo di Jean-Claude Izzo alla Spagna di Alicia Giménez -Bartlett, fino alla Cina di Qiu Xiaolong e all'Africa di Moussa Konaté, un percorso nel giallo contemporaneo e nel suo rapporto con...